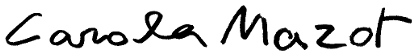安东尼▪卡尔贝
Chiara GATTI
Dejanira AMICO
迪诺▪维拉尼
恩佐▪德马迪诺
佛朗哥▪比内洛
佛朗哥▪佛萨
佛朗哥▪洛伊
Gabriella NIERO
詹尼▪达赤尤
Gianni PRE
乔治▪皮拉
Giorgio SEVESO
Gioxe DE MICHELI
朱利奥▪卡斯帕罗迪
Giuseppe POSSA
朱塞佩▪布勒斯
利亚纳▪波陀娄
Mafalda CORTINA
Maria Clara BOSELLO
Mario BORGESE
马里奥▪德米凯利
纳塔尔▪扎古里
Nicoletta COLOMBO
奥番果▪勘比易
保罗▪列兹
皮尔路易吉▪沸鲁阿
罗伯塔▪阿瓦洛
罗伯托▪玛尤留
蒂齐亚纳▪卡尼特洛
维拉▪眉内古佐
Veronica MOLINARI
Nicoletta COLOMBO
L’umanità dipinta di Carola Mazot, nel segno della libertà24-09-2025
L’invisibilità o la scarsa visibilità delle donne artiste nel passato e, possiamo tranquillamente affermare, anche in tempi relativamente recenti, non è altro che lo specchio della società; l’arte cioè è una realtà in cui si riflettono i rapporti sociali di genere.
Anche oggi le donne artiste, nonostante una innegabile maggior attenzione ad esse riservata in rapporto al passato, sono decisamente meno presenti dei colleghi uomini nelle aste, nelle grandi rassegne, nelle biennali internazionali; insomma, è ancora lontano il riconoscimento del contributo femminile al dibattito culturale internazionale.
Un gran numero di artiste è diventato, nel trascorrere degli anni e dei decenni, immeritatamente “invisibile”, sollecitando oggi il bisogno di un recupero di informazione e di risveglio della memoria collettiva.
Con questo spirito, in relazione a Carola Mazot (1929-2016), è stato istituito a Milano nel 2001 l’archivio dedicato all’artista e nato in correlazione con lo spazio Atelier Mazot Milano, due presenze sorprendentemente attive nell’organizzazione di mostre monografiche, di partecipazioni a collettive e a iniziative istituzionali e museali.
Ma risaliamo agli inizi: le prime prove pittoriche di Carola, che denotano una raggiunta personalità, quella cioè da cui emerge l’“impronta” dell’artista, risalgono alla metà degli anni cinquanta, eppure la sua genesi artistica avveniva molto tempo prima, addirittura all’epoca dell’adolescenza.
Il nonno, Vettore Zanetti Zilla (1864-1946), celebrato naturalista e postimpressionista veneziano, allievo di Giacomo Favretto e di Egisto Lancerotto, trasmetteva alla giovanissima nipote i segreti del colore, che per i pittori veneti a cavallo tra Otto e Novecento rappresentava per tradizione un elemento da fondere nella luce per condensare le forme senza passare per la strettoia dei contorni disegnati.
Si trattava già dagli esordi di assumere una visione sintetica e non analitica, quella poi maggiormente sviluppata dalla giovane al suo arrivo a Milano, dove era rientrata nel 1946 dopo essere sfollata a Tremezzo durante il periodo bellico. Milano era a quel tempo una città che si riappropriava della propria identità propulsiva, riflessa anche sul versante del milieu artistico.
Negli anni postbellici e per tutto il decennio dei ’50 si succedevano nel contesto ambrosiano correnti e movimenti che vedevano il contrapporsi polemico tra figurazione e astrazione, nella successione di Realismo, Movimento Arte Concreta, Spazialismo, Arte Nucleare, Ultimi Naturalisti, Realismo Esistenziale, fino alle soglie degli anni sessanta con il superamento dell’Informale latamente inteso a favore dei linguaggi concettuali.
Carola Mazot, a fronte della molteplicità dei linguaggi artistici, si manteneva fedele alla figurazione, prediligendo gli insegnamenti di Donato Frisia (1883-1953), pittore che disegnava dipingendo, e di Lorenzo Pepe (1916-1984), scultore antiaccademico, maestro nel rendere efficaci i brividi esistenziali della materia.
La frequentazione dell’Accademia di Brera le consentiva di seguire i corsi di Giacomo Manzù (1908-1991), di Marino Marini (1901-1980) e di Pompeo Borra (1898-1973). La vivacità della Milano culturale degli anni sessanta immetteva l’artista in un crogiolo di amicizie con esponenti di varie correnti, molti dei quali frequentatori, come lei, del bar Jamaica nel quartiere di Brera: Bruno Cassinari, Roberto Crippa, Mario De Micheli, Gianni Dova, Luigi Grosso, Virgilio Guidi, Franco Loi, Giuseppe Migneco, Ennio Morlotti, Bianca Orsi, Aligi Sassu, Ernesto Treccani, e altri intellettuali.
La mostra odierna celebra l’attività di Carola sul versante della figura umana, tema classico che affonda le radici nella sua formazione accademica, operandone per contro una elaborazione antiaccademica nel segno di un espressionismo malinconico, neoromantico.
La vicinanza e la frequentazione degli esponenti del Realismo ha spesso indotto la critica ad allineare la figurazione di Carola alla poetica realista; in realtà gli innamorati, con assidua affezione replicati dagli anni sessanta in poi, le coppie, i volti, i fidanzati dipinti in atteggiamento di reciproca attrazione, sottendono una forte tensione spirituale, una vena esistenziale e malinconica che si traduce in un linguaggio statuario, incisivo, fortemente sintetico nella forma e nel colore. Come non apparentare allora le soluzioni di intimità di Mazot alle pitture del giovane gruppo milanese del Realismo Esistenziale, attivo tra i secondi anni cinquanta e i sessanta con proposte alternative all’ Informale e all’esistenzialismo politicizzato?
Alcune livide cromie contenute nelle linee schematiche di Carola, affondate nei silenzi di volti tesi in soluzioni masaccesche, si prospettano come specchi di un’umanità ribaltata al di fuori dello spazio e del tempo. La forza rappresentativa si modula energeticamente in scie lineari dinamiche, residui di energie misteriose, motivi che richiamano alla mente le figurazioni di maestri coevi, quali Domenico Purificato, pittore neorealista, al tempo (anni settanta) direttore dell’Accademia di Brera, e Remo Brindisi, artista di successo in quel giro di anni e interprete di una umanità attonita e surreale.
Anche nelle sculture di Mazot, qui rappresentate da teste scolpite secondo una trattazione ruvida, sintetica, arcaizzante, ricompare la caratterizzazione empatica e psicologica del personaggio ritratto; vi si legge l’insegnamento sinottico, etruscheggiante di Marino Marini, maestro del ritratto plastico, tanto quanto l’amore per le materie grezze del primordio, probabilmente osservate in Lorenzo Pepe, scultore di malinconie esistenziali.
Una sezione di particolare interesse è riservata in mostra ai numerosi ritratti definiti con tratto rapido e schematico, testimonianze delle frequentazioni con intellettuali, poeti, critici d’arte, scultori, pittori: si tratta dei volti di Mario Bardi, Mario De Micheli, Virgilio Guidi, Giuseppe Migneco, Bianca Orsi, Vitale Petrus, Enio Tomiolo, Togo (Enzo Migneco), Ernesto Treccani, Emilio Vedova.
Un piccolo nucleo di lavori ci ricorda che Carola, oltre a esprimere nei suoi quadri una carica energetica quasi al maschile, ha conservato una dolcezza e una sensibilità femminile che si esprimono attraverso il tema della giovane violinista; in realtà si tratta dei ritratti della figlia musicista Caterina, e dell’intimismo domestico di Ragazza con cane.
La parentesi romantica e famigliare pare scorrere come un fuggevole intervallo che prelude alla sezione titolata L’energia, in cui le temperature si accalorano tanto nella tavolozza, che apre a maggiori articolazioni cromatiche, quanto nel dinamismo dei soggetti, svolti su dimensioni di supporto più importanti.
Il vigore degli atleti in corsa, dei calciatori, dei giocatori, cerca spazio nell’estensione delle linee dinamiche dei corpi, stirati ad assecondare i flussi del moto; il colore si addensa in masse che si propagano in traiettorie diagonali e sezionano la superficie delle tele in cerca di libertà. Affermava l’autrice, riferendosi alla serie degli “atleti”: “Un soggetto che mi affascina e che mi dà più libertà perché il pennello si lancia seguendo spinte irresistibili”.
In fondo, l’appropriazione del ruolo di artista al femminile in un sistema orientato a privilegiare il genere maschile dominante, è stato per Carola il miglior modo, da donna di cultura, per dimostrare con i fatti la propria ininterrotta vocazione alla libertà.