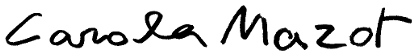Antonio CARBE'
Chiara GATTI
Dejanira AMICO
Dino VILLANI
Enzo DE MARTINO
Franco BINELLO
Franco FOSSA
Franco LOI
Gabriella NIERO
Gianni DAZZIO
Gianni PRE
Giorgio PILLA
Giorgio SEVESO
Gioxe DE MICHELI
Giulio GASPAROTTI
Giuseppe POSSA
Giuseppe PROSIO
Liana BORTOLON
Mafalda CORTINA
Maria Clara BOSELLO
Mario BORGESE
Mario DE MICHELI
Natale ZACCURI
Nicoletta COLOMBO
Orfango CAMPIGLI
Paolo RIZZI
Pier Luigi VERRUA
Roberta AVALONE
Roberto MAIOGLIO
Tiziana CANITERO
Vera MENEGUZZO
Veronica MOLINARI
Dejanira AMICO
Corporeità e alterità. Sul «realismo» nell’opera di Carola Mazot24-09-2025
Fin dall'invenzione della fotografia la dialettica fra riproducibilità tecnica dell’immagine e rapporto tra arte e realtà ha rappresentato uno dei principali motori teorici della modernità. Quando, negli anni Cinquanta, Carola Mazot si forma all’Accademia di Brera – in un decennio cruciale per il realismo italiano animato, fra gli altri, da Raffaele De Grada, Mario De Micheli e Ernesto Treccani – il dibattito critico sulla rappresentazione del reale è dominato dal tentativo di oltrepassare l’antinomia tra mimesi e astrazione, alla ricerca di una figurazione capace di restituire la frattura storica del dopoguerra.
Mazot condivide con molti coetanei la diffidenza verso le grandi narrazioni politiche che avevano alimentato l’impegno dei maestri. L’esperienza della Shoah, l’ombra di Hiroshima e la tensione della Guerra fredda alimentano, nella sua generazione, un sentimento di angoscia e di disgregazione identitaria: l’individuo si percepisce minacciato da forze storiche che eccedono la sua misura e si sente chiamato a difendere un nucleo di soggettività fragile ma irriducibile. Se nell’opera di artiste che avevano vissuto direttamente la tragedia bellica, come Bianca Orsi – anch’essa allieva di Brera – il corpo appare lacerato dall’esperienza novecentesca, nelle tele di Mazot l’angoscia di un’umanità minacciata dalla Storia viene filtrata attraverso una dimensione intima. Questa prospettiva riecheggia la «questione privata» che connota la letteratura italiana del dopoguerra: una scrittura, da Vittorini a Pavese, da Fenoglio a Calvino, che ha per sfondo la guerra ma per protagonista la ricerca dell’«altro» femminile.
In questo clima culturale si colloca la vicinanza di Mazot al Realismo Esistenziale milanese, la cui dichiarazione programmatica – redatta da Banchieri, Ceretti, Ferroni, Guerreschi, Romagnoni e Vaglieri – invocava la necessità di «rimettere la cosa davanti a noi e dipingerla senza mitizzazioni». L’oggetto privilegiato da Mazot è il corpo, e in particolare, negli esordi, il volto umano. La scelta di un tema in apparenza tradizionale nasconde una strategia analitica: l’artista affronta la figura in termini seriali, proponendo sequenze di Volti e Coppie che scandagliano il soggetto attraverso variazioni minime, quasi si trattasse di un esperimento fenomenologico.
La serialità posiziona la sua ricerca tra esistenzialismo e cultura di massa, poiché la ripetizione non è mai meccanica: ogni quadro rintraccia il residuo di singolarità che sopravvive alla riproducibilità tecnica e al consumo iconico. Questo metodo si traduce in un linguaggio plastico in cui la sintesi dei lineamenti – definita da tratti scuri ma sfocati – sospende i volti fra presenza e dissolvenza. Figure prive di contesto, spesso emergenti da campiture d’ombra, sembrano corpi frantumati dalla storia; la frattura, tuttavia, viene subito ricomposta nel gesto pittorico, che trasforma la lacerazione in vibrazione cromatica, salvando l’immagine sull’orlo dell’evanescenza e lasciando intravedere, nella solitudine, la promessa di un’azione futura.
Nello stesso orizzonte di crisi prende forma anche il tema dell’incomunicabilità, centrale nei dipinti di coppie: corpi vicini eppure impermeabili, sguardi che si sfiorano senza incontrarsi, lontani echi di Brancusi nel motivo del bacio. La pittura registra quel silenzio come dato strutturale dell’esistenza contemporanea, sottraendo la figura tanto alla retorica engagée quanto all’astrazione decorativa. Questa tensione si regge su una forte volumetria pittorica: le figure, scavate dalla luce, rivelano la formazione scultorea di Mazot: una plastica fondata sull’intreccio di pieni e vuoti, sulla scomposizione dei piani e sulla frantumazione della massa, approfondita anche attraverso il dialogo con lo scultore Guido Di Fidio, suo marito. Assimilata questa grammatica, Mazot la traduce in pittura: la linea diventa scalpello, i corpi si articolano in campiture angolari, i contorni – netti ma interrotti – aprono le forme a una risonanza interna. Il risultato è una pittura densamente plastica, dove la superficie vibra di luce.
La ricerca si sviluppa negli anni Ottanta, in particolare nella serie degli Atleti: pennellate oblique e tagli diagonali restituiscono peso, fatica e attrito della carne nello spazio. Qui affiora il carattere performativo della sua pittura: i grandi formati la costringono a dipingere con l’intero corpo, e le traiettorie gestuali restano impresse sulla tela, come documentano le rare fotografie che la ritraggono al lavoro, quasi danzante.
Lo spettatore viene cooptato in una trama di forze che lo avvolge e indirizza lo sguardo. Mazot erige una verticalità plastica che condensa la gravitas del corpo scultoreo in campiture di colore: la luce incide, la linea segna, il pigmento stratifica volumi cesellati a scalpello. Pieni e vuoti si trasformano in campi di tensione, misurando l’energia interna dell’immagine.
Nella produzione matura questa fisicità raggiunge il culmine. I corpi sono forgiati da planate successive di colore che li sedimentano come strati geologici: piani che si urtano, si sfiorano, si respingono, generando un moto alterno di compressione ed espansione. Ne risulta una figura insieme compatta e pulsante, trattenuta su un confine instabile che ne amplifica la forza emotiva.
Nell’opera di Mazot prende forma un’estetica della soglia: ogni immagine resta sospesa fra presenza e dissolvenza, fra ermetismo e comunicazione, fra slancio e caduta. Nella fitta trama di corpi, monumentali nelle dimensioni eppure refrattari a ogni retorica celebrativa, l’artista affronta la questione cruciale della sua ricerca: il gesto pittorico diventa azione muscolare e respiro, e la superficie si fa materia sensibile. Così la pittura riafferma la centralità del corpo – luogo primario dell’esperienza e deposito irriducibile di verità – una realtà fisica che nessun dispositivo di riproduzione potrà surrogare.